In questa sezione sono presenti diverse lapidi e lastre marmoree di ambito locale, oltre che paramenti, testi sacri e scritti di Sant’Alfonso Maria de Liguori.
L’ingresso principale si apre sulla Piazza Umberto I, immette nel cortile, a giardino, dal quale due rampe di una scala portano al Salone degli Stemmi e alle stanze del Vescovo.
Lungo le rampe della scalinata e nel salone degli stemmi -il nome deriva dalla presenza in questa stanza di 69 effigi di altrettanti Vescovi – è ospitata la sezione “Luoghi Alfonsiani” del Museo Diocesano, che comprende, tra l’altro:
- una lapide sepolcrale del Vescovo Adelardo (999);
- un frammento del pavimento musivo che apparteneva alla cattedrale, XII secolo, raffigurante un cavaliere che affronta un serpente;
- frammenti di una lastra comitale del XV secolo;
- un coperchio sepolcrale, in bassorilievo, di Andrea Lollo, del 1595;
- un affresco del 1614 che riproduce l’obbedienza del clero al vescovo attribuito a Cesare Calise;
- un presepe napoletano;
- una croce, con base a crocefisso, in ottone, del 1742;
- pianete ed altri parametri sacri;
- una sedia episcopale utilizzata da Sant’Alfonso e da lui decorata;
- scritti di Sant’Alfonso;
- mitria di Sant’Alfonso;
- paramenti sacri del XVII e XIX secolo;
- dipinto dell’Annunciazione, Angelo Michele Ricciardi, XVIII secolo;
- reliquiario di Sant’Onofrio, 1585;
- reliquiario Sant’Agata, 1844.
Dal salone si accede alla stanzetta di Alfonso Maria de Liguori, (1762-1775) già avvocato all’età di 16 anni, poeta, scrittore, mistico e missionario, proclamato santo nel 1839.
In essa, umile e modesta, si trovano oggetti e suppellettili usati dal Vescovo.
Tra i vescovi che abitarono nel palazzo si ricordano anche: Felice Peretti (1566-1571) francescano conventuale, inquisitore ed esperto di teologia al Concilio di Trento, eletto Papa col nome di Sisto V nel 1585; Feliciano Niguarda, (1583-1588), frate domenicano, docente di Teologia all’Università di Vienna; Infine, Alessio Ascalesi, (1911-1915), alto, maestoso e solenne ma anche umile e paterno. Dopo il terremoto del 1456, fu il vescovo Ettore Diotallevi (1608-1635) a volere il restauro dell’episcopio, aggiungendo fabbriche e pitture.
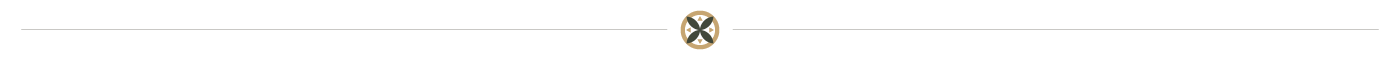
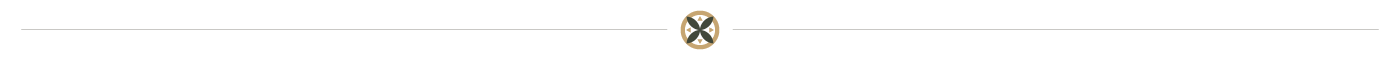
La Chiesa del Carmine nell’omonima piazza è in un punto nevralgico nel centro storico, a metà strada tra il Castello Ducale e la Cattedrale.
A pian terreno si possono visitare le grotte e un cunicolo affrescato nel 1614: il ciclo di affreschi di ispirazione biblica con episodi del Vecchio Testamento, fatto eseguire dal Vescovo Diotallevi.



































